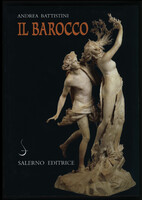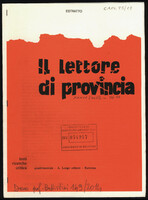Doni di libri. Le dediche di Andrea Battistini nei libri della Biblioteca Umanistica Raimondi
Nella cultura del Barocco
Se per un attimo ci si trasforma in testimoni immaginari dell’epoca in cui la carriera universitaria del professor Battistini aveva cominciato a prendere uno slancio tutto ascendente, a cavallo fra gli anni ’70 dell’approdo di Raimondi alla Facoltà di Lettere e i primi anni ’80 della sua chiamata a professore ordinario, a Bologna era di casa un’idea di connessione quasi diretta fra il Barocco e il Novecento. Precipuo problema critico era di mostrare questo connubio sul piano di lingue ed esperienze letterarie concrete, da porre a loro volta in connessione con una serie di opportuni paradigmi scientifici.
Ecco, questo è proprio un punto cruciale per testimoniare la stoffa interpretativa di Battistini, efficacissima nella sua capacità di armonizzare nel suo pensiero critico gli statuti retorici (segnatamente attenti alle proprietà gnoseologiche della metafora, secondo Battistini vero e proprio motore propulsivo di ogni macchina o metamorfosi verbale), le fantasmagorie liriche e i principi del metodo sperimentale con le proprie manifestazioni saggistiche, fra Galileo e Vico, magari passando per quel Campanella che dal Guarini aveva tratto un elogio del “genere misto”. E i princìpi combinati dello svelare e del rigenerare trovano una ragione generativa nei paragrafi storici non meno che formali.